
Al Comunale di Bologna uno dei migliori West Side Story mai visti in Italia.
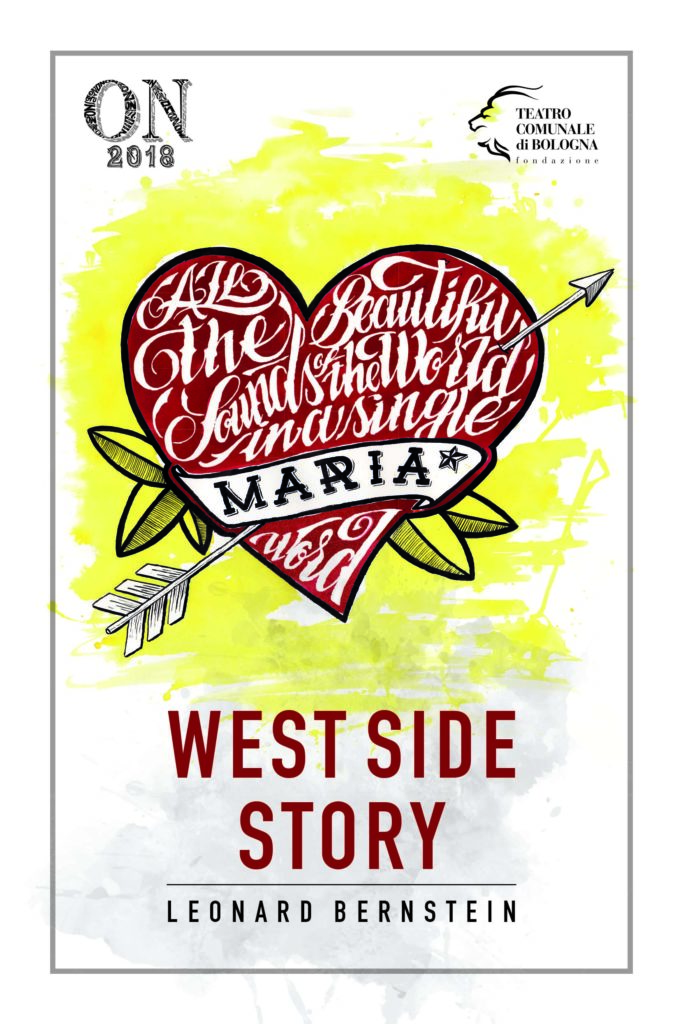 di Sandro Avanzo
di Sandro Avanzo
2018 anno delle ricorrenze: 100 anni dalla nascita di Leonard Bernstein, 25 dalla fondazione della BSMT, 10 di collaborazione tra il Teatro Comunale di Bologna e la scuola diretta da Shawna Farrel.
L’ente lirico emiliano non poteva che celebrare queste coincidenze mettendo in produzione per l’attuale stagione estiva il più classico dei musical, proprio quel West Side Story che 61 anni fa fu spartiacque nella storia della scena musicale americana e che da mezzo secolo è stato adottato dalle sale dei teatri lirici di tutto il mondo (qui la presentazione dello spettacolo).
Sei sole repliche (11-17 luglio) affollate in assoluti sold-out, sei meritati trionfi per i diplomandi e le diplomande che non avrebbero potuto sperare in un congedo più felice dalla scuola dove hanno studiato intensamente per tre serrati anni.
Come è noto la strada di tale successo è stata costellata da ostacoli di ogni tipo, a partire dalla concorrenza con un altro allestimento presente nei cartelloni lirici italiani di questa stagione (al Carlo Felice di Genova e al Teatro dell’Opera di Firenze), in un contenzioso per i diritti non dichiarato pubblicamente risolto in un contratto in base al quale solo allievi in attività alla BSMT avrebbero potuto calcare il palcoscenico, senza essere affiancati o sorretti da figure ospiti di maggior esperienza professionale.
Tutti sappiamo quanto fondamentali siano nella messa in scena di West Side Story le azioni coreografiche ideate da Jerome Robbins e come i danzatori impegnati in quei numeri necessitino per interpretarli di una consolidata preparazione di danza classica, disciplina non prevista specificatamente nei corsi della BSMT. A ciò si aggiunga l’ulteriore vincolo inserito nel suddetto contratto: vietato l’utilizzo delle coreografie originali. Con lacci tanto stretti si sarebbe potuto realizzare uno spettacolo di buon livello? Quale maga o buona strega avrebbe potuto rompere il maleficio? Non una maga ma una fata, una professionista di livello internazionale, s’è palesata nelle sembianze di Gillian Bruce che è riuscita a compiere il miracolo di riprodurre i movimenti Robbins senza le asperità di Robbins e di trasformare in provetti ballerini degli allievi preparati soprattutto nelle discipline canore.

Con grande intelligenza e sensibilità la Bruce ha saputo smontare i singoli numeri, enucleare posizioni, figurazioni e passi originali, per poi riassemblarli in modi e momenti del tutto nuovi e originali, conservando il senso e il sapore dell’ormai antico standard broadwayano e nel contempo mimetizzando le semplificazioni da lei apportate. Perfettamente consapevole dei meriti e limiti degli allievi della scuola e dei livelli a cui avrebbe potuto portarli, ha realizzato coreografie adeguate alle loro capacità, spingendoli a livelli massimi ma per loro raggiungibili. Con risultati stupefacenti (… nel senso di momenti che hanno suscitato stupore) come quando ha eliminato l’iconico schioccar delle dita che scandisce i ritmi del prologo per poi recuperarlo e svilupparlo nel numero Cool dove l’articolazione delle battute e il significato dei passi hanno consonanza con quelli del prologo.
La coreografa inglese dimostra per l’ennesima volta il suo talento creativo, in grado di mettersi al servizio dello spettacolo in cui si trova impegnata, e il suo costante interesse a sottolineare lo spirito e il significato della scena musicale che va a disegnare, sposando e dando forma alle idee dei differenti registi con cui collabora. Proprio per questo in moltissimi affermano da tempo che sarebbe giunto per lei il momento di fare quel passo naturale che la dovrebbe portare da coreografa a regista tout court dell’intero spettacolo. Il mondo del musical italiano ne trarrebbe solo vantaggi; mentre in parallelo ci si augura che il West End dove è molto apprezzata non finisca per rapircela.

Anche nel caso attuale, senza l’apporto della Bruce l’intelligente lettura che Gianni Marras ha dato del lavoro di Bernstein-Laurents-Sondheim non sarebbe stata realizzabile, e non solo per l’importanza che le coreografie assumono nella complessità dell’insieme. Il regista sardo ha potuto organizzare l’intero suo disegno narrativo proprio intorno ai numeri (e grazie ai numeri) di ballo che diventano non un’aggiunta espressiva, ma lo sviluppo naturale delle vicende rappresentate.
Il punto focale della regia sta nell’aver individuato e organizzato lo spettacolo lungo una linea orizzontale in cui si svolgono i contrasti e le lotte tra gli immigrati portoricani Sharks e gli indigeni Jets e una linea verticale (quella del balcone) lungo cui si eleva alto l’amore tra Maria e Tony, possibile esempio di un mondo migliore, più giusto, uguale e felice per tutti… somewhere.
La scena iniziale in cui tutti i personaggi corrono frenetici e senza meta come esseri impazziti e disperati dentro un labirinto fatto di pannelli mossi vorticosamente introduce bene al senso della sua lettura. Altro aspetto particolarmente interessante (e vincente) della messa in scena diventa la declinazione al femminile dell’intero dramma, in cui le donne vengono viste come le vittime principali della violenta follia maschile – Anita perde Bernardo come Maria perde Tony – e dunque i loro sentimenti e i loro comportamenti, il complesso rapporto reciproco (A Boy Like That) vengono proposti in primo piano e seguiti con particolare attenzione. Così assume un senso davvero significativo il sipario che si chiude proprio su Anita e Maria, ultime a lasciare la scena affrante e sconfitte, al seguito e non in testa al corteo funebre per Tony come solitamente si rappresentano.

Nel suo felice allestimento di questo West Side Story, con Regtime forse il miglior musical da lui realizzato sul palco del Comunale felsineo, Marras è stato assistito da collaboratori di assoluto talento come il lighting designer Daniele Naldi che ha dato forma, importanza e continuità a ogni azione scenica valorizzandone i colori e sostenendone i particolari e gli elementi più rilevanti come nella scena della palestra, quando i tagli di luce hanno posizionato in rilievo l’incontro tra Tony e Maria portati in evidenza come in vero primo piano cinematografico. L’illuminazione e i tagli d’ombre hanno finito per raccontare tutto ciò che le azioni e la musica non potevano ulteriormente dire. Sono riusciti anche a rendere semplice e chiara la complessa scena del balletto del secondo atto quando, sulle note astratte di Somewhere, l’intera compagnia ripete in sogno il drammatico duello mortale tra Bernardo e Riff.
Molto espressive si sono rivelate le scenografie di Giada Abiendi che ha saputo fondere con intelligenza gli elementi concreti (lo store di Doc, la palestra, le scale del balcone) e le scenografie proiettate (il ponte di Brooklyn, gli edifici di mattoni a vista), trasformando in questa sintesi/alternanza di verità/virtuale il paesaggio degli slum in un paesaggio dell’anima.
Davvero pregevoli anche i costumi di Massimo Carlotto, colorati come richiedeva la moda latina, ma mai eccessivi o volgari se non nella misura necessaria a definire il carattere dei personaggi (cfr. la portoricana bionda). I tanti talenti eclettici del direttore d’orchestra Timothy Brock ci erano noti da tempo sia in campo classico che contemporaneo (si pensi che ogni volta raccoglie trionfi anche al Festival del Cinema Ritrovato) ma mai ci saremmo aspettati di sentire un’orchestra che sapesse fondere insieme ma anche rendere distinte le sonorità degli archi, degli ottoni e delle percussioni nel difficilissimo inizio scena del ballo in palestra. Davanti a cotanta maestria si può solo tacere, entusiasmarsi e applaudire!

Gli allievi della BSMT si sono dimostrati in grado di sostenere vocalmente e sul piano interpretativo ruoli davvero improbi, non da diplomandi (21-25 anni!!!!) ma da autentici professionisti del palco, tanto che nel vederli in scena tornava alla memoria lo slogan di lancio del film Romeo e Giulietta di Zeffirelli, quando gli strilli pubblicitari proclamavano Dopo quattro secoli l’amore torna ad avere 15 anni! e veniva da pensare che sarebbe stato uno slogan utilizzabile anche per questo allestimento.
Ecco: davvero una delle rare occasioni di vedere e di vivere lo spettacolo con performer anagraficamente adeguati all’età prevista dal copione (il gap relativo al ruolo dei tre adulti è stato ampiamente compensato dalle capacità espressive dei tre attori: Domenico Nappi come Doc, Andrea Rodi come Schrank e Luca Asioli come Ufficiale Krupke che una volta tanto non risultavano fastidiosi nei panni di figure mature). Di Timothy Pagani, che qui è Tony, c’era già stata l’occasione di valutare positivamente le doti di intonazione e le capacità d’attore. In questa circostanza va riconosciuto che la sua naturale baldanza e la sua padronanza del palco hanno giovato allo spettacolo e regalato spessore e presenza scenica a una figura solitamente slavata per quanto fondamentale. Voce potente, ma anche ricca di calde sfumature, ha dato bella prova di sé e ha saputo emozionare ed entusiasmare il pubblico sia in Maria che in Tonight.
Ovviamente Tonight è stata condivisa con la coprotagonista Caterina Gabrieli che si è mostrata una Maria tanto graziosa e dolce nei modi quanto vocalmente incantevole e capace sostenere con apparente naturalezza cambi tonali di notevole complessità. Non è necessario essere dei profeti per affermare fin da adesso che siamo di fronte a una delle prossime star del mondo del musical italiano.
E la stessa non-profezia si può fare anche per Francesca Ciavaglia che ha sostenuto il ruolo di Anita. Più ancora che nello showstopper America (terminato in trionfo di meritati applausi) la si è potuta apprezzare in una grande interpretazione di A Boy Like That, eseguito con una rabbia e una disperazione perfettamente adeguate a una ragazza appena informata della morte del fidanzato e che non vede prospettive davanti a sé.
Tutti i presenti sulla scena andrebbero citati uno per uno, perché se lo meriterebbero per quanto hanno saputo esprimere sul palco (evidentemente questo è stato un corso particolarmente fortunato e ricco di talenti alla BSMT). Nessuno di loro se abbia a male se ci si limita a fare ancora il nome di Francesca Marsi, che ferma immobile a un lato del proscenio ha intonato un magico Somewhere calato direttamente dall’empireo, ma anche il nome di Elisa Gobbi che ha saputo reinventare il personaggio di Anybody’s distaccandosi dai tradizionali tratti della protolesbica per farne una ragazzina resa forte dalle circostanze della vita e decisa a rompere il perimetro dell’emarginazione.
Resta da dire solo del rammarico che un’edizione così importante di West Side Story, di certo tra le migliori in assoluto tra le tante viste in Italia anche in paragone con i molti allestimenti stranieri da tour approdati nei nostri teatri, non abbia la possibilità di essere portata a un pubblico più vasto che meriterebbe di apprezzarla e applaudirla.



